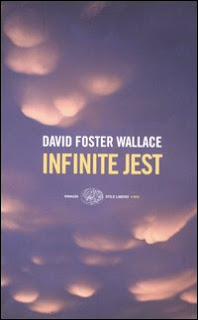Viaggiare insieme. Fare dei figli. Non rinunciare alla
possibilità di trasmissione di esistenze legate ad un filo d’amore, quando va
bene. Invece ti lascio insieme ai ricordi del nostro tempo. Io ho fallito
perché non ho più creduto a noi, e a te. Ti lascio per sempre, e sarà così
rapida questa notizia che ti attraverserà come una fitta, almeno spero, e ti
abbandonerà subito, lasciandoti un piccolo vuoto. Dolore e sconforto potrai
metterceli e non pensarci più. Ti auguro di fare così e di non soffrire per me,
non sentirti in colpa se non vuoi stare male, è la cosa più giusta da fare.
Nella terra dove andrò a morire il nostro distacco avverrebbe serenamente, e
dato che già distanti lo siamo non angustiarti, io sono già morto, è successo,
tu stavi leggendo ed io già non c’ero.
Lei è lontana qualche passo, è china a raccogliere dei
fiorellini e il vento le smuove il vestito leggero che diventa un insieme di
piccole onde e le vorrei scattare una foto ma ho dimenticato la macchinetta in
albergo. Mi giro e l’oceano mi sorprende di nuovo, per un attimo ho paura e poi
mi ci abituo, ma quando torno ad osservarlo è sempre troppo grande, immenso, lo
guardo e cerco un punto che non c’è, non c’è mai, troppo. Io sono stanco e
abbiamo fame tutti e due, ma dobbiamo aspettare mezz’ora prima che la corriera
riparta per la città. Fra due ore avremo tutto a disposizione, l’albergo e i
ristoranti, le passeggiate fra i turisti, l’odore di patatine fritte e pesce
fritto e qualsiasi altra cosa che s’avvicini al naso, ma adesso siamo fermi e
allo stesso tempo siamo finalmente stranieri in terra straniera, affamati e
ansiosi di arrivare, di avere ristoro e compassione, finalmente.
Intorno c’è solo oceano e scogliere, uno spiazzo per i
pullman, il chiosco per i turisti, in pietra bianca, gelido all’interno per
l’aria condizionata, pieno di statuine, cartoline e altre cose che non distinguo,
che non riesco a guardare a lungo, che mi sembrano insignificanti, ma non so
neanche se lo sono effettivamente. Come l’attesa e la noia, non so più se mi
piacciono o se le detesto, io che mi sforzo di non fare il turista caprone che
calpesta il mondo e lo sradica ingordo, e ci pianta la sua bandierina e la
osserva tronfio, io che so o sapevo godere mentre aspettavo, la nave, le
scalette, le file, gli scorci di paesaggio, i vicoli scarni, i panni stesi
fuori. Allora ripenso ai viaggi che abbiamo fatto, io e Lei, ma questi momenti
non ci sono, ho solo i bei ricordi, le cartoline mentali che ci siamo spediti a
futura memoria e gioia, gli spruzzi d’acqua e le orme nel deserto, i tuffi
dagli scogli e i pesci colorati. Cieli, cieli d’ovunque, stellati, tersi,
minacciosi, infuocati e spenti, stelle cadenti, desideri espressi mentre le
labbra esaudivano.
-
Mi reggi la borsa?
-
…
-
Oi, mi reggi questa?
-
Che?
-
La borsa, me la reggi?
-
Ah, si scusa.
-
a che pensavi?
-
A niente.
-
Però sembravi così preso.
-
In effetti, qualcosa c’era, ma mi sfugge, non so se è
una cosa cui penso o se penso a quello che sto pensando.
-
Basta che non cadi di sotto, Einstein!
No, non cado, anche se è un’idea, sarebbe ottima, se ci si
potesse tuffare senza farsi male, così, da un centinaio di metri, verso il mare
di sotto, liberi da tutto. Se fosse possibile assaporare le sensazioni mentre
si è in caduta libera. Ma non ci credo, mi sembra troppo veloce, dovrei provare
il paracadutismo, me lo dico sempre, ma poi me lo dimentico. Ma come fa! È lì
che sorride e mi guarda, mi prende in giro perché dico delle scemenze
incredibili e mi sopporta, è felice, stanca come me ma è felice, sa ancora
aspettare e apprezzare questi momenti di nulla estasiante, di polvere calda e
accogliente, di sguardi fra persone di lingue diverse che si passano accanto a
voce bassa e con discrezione, tutti ad osservare questo punto estremo d’Europa,
a trattenere il fiato mentre ci si avvicina a piccoli passi sul bordo della
scogliera, dove non c’è neanche un appoggio per le mani, per sporgersi in
avanti senza rischiare di cadere. Oppure dovrebbe fingere, ma fingere con una
maestria che non è concepibile se non si vuole pensar male ad ogni costo, gli
occhi non dovrebbero mentire, i ciuffi di capelli che il vento fa frusciare, le
ciocche che si attaccano agli estremi della bocca, tutto sta a dimostrare la
sua felicità. Ci credo, le credo, maledetto io che non sono più capace, ho
dimenticato le basi, ho buttato la mappa nel fuoco, ho smarrito il senso
dell’orientamento vitale, non mi sento più nessun vestito comodo addosso,
nessun colore è giusto, nessuna misura: troppo stretto, troppo largo, fa
difetto, è pesante. Lo specchio, lo specchio. Io non mi specchio più, mi guardo
di sfuggita per non trovare difetti, alito sulla superficie vitrea per creare
confusione, cerco di uscire dal bagno prima possibile, lascio la mia coscienza
a fare i conti con qualcun altro, che si trovi anche lei un’altra coscienza. Scappo
al lavoro, corro in ufficio, chiunque incontro devo sembrare in perenne fretta,
è tardi, è sempre tardi per tutto. Lei resta ancora salda affianco a me e
sembra non soffrire, io quasi ci provo ad esasperarla, faccio dei tentativi che
vanno sempre a vuoto, come se lei sapesse, o come, ed è quello che temo, che
lei sia troppo lontana dalla mia inadeguatezza per accorgersi. Lei è rimasta
umana mentre vive, io mi sono trasformato in cavia da laboratorio e scienziato
pazzo allo stesso tempo, mi osservo e mi costringo, analizzo sadicamente e mi
premio, tutto da solo, vicino alla follia, se fosse facile accorgersi di essere
pazzo, ma non lo è.
-
Dai alzati, che stiamo per partire, mannaggia che ti
sei dimenticato la macchina fotografica, guarda che bello, dammi un bacio
almeno, mettiamoci in posa per la natura, facciamo che lassù qualcuno ci sta
guardando per decidere se sbarcare sulla Terra e ci vede e capisce che si deve
sbrigare che sennò finisce lo spettacolo.
Guardare il mondo da un aereo mi rilassa, il sottofondo del
motore e il brusio quasi inavvertito degli altri passeggeri mi cullano e mi
rassicurano. La perfezione sarebbe poter stendere le gambe, addirittura
sdraiarsi ed aspettare l’arrivo. Un aereo trasparente. Appena scesi il pensiero
che sia finita qui mi coglie e sento che non mi lascerà più. Il disfacimento è
completo, il mio unico obiettivo è non vedere che vuoto intorno a me, è non
sentire altro che il mio respiro, e se possibile il mio battito cardiaco. Il
mio lento morire dovrebbe avvenire al freddo, mi immagino che cammino nella
neve, magari nella tormenta, sono un esploratore del suicidio, uno dei più
bravi, e dunque non lascerò che la mia traccia, immobile e ghiacciata, e chissà
se sarà ritrovata. Sento già freddo mentre sistemo le valigie e le borse nel
taxi, mentre osservo il tassametro e le luci della città in piena notte a Roma
e quando la guardo, vedo che anche Lei ha abbassato le difese e sta sognando di
essere altrove. Poverina, c’è ancora da andare a prendere il treno, poi tre o
quattro ore e ancora salire nella nostra macchina e arrivare a casa che sarà
giorno e stenderci lungo qualsiasi cosa che sia morbida e grande abbastanza da
contenerci. Senza contare la mia decisione.
Quand’è che sono diventato quello che sono.
Nella sala da concerto l’attesa sta diventando snervante, è
passata già mezz’ora e l’orchestra ancora non è entrata, la campanella ha già
suonato tre volte nell’indifferenza generale, si è mescolata al brusio
compiaciuto, agli smoking e agli abiti da sera, ai gioielli e ai cellulari che
non si spengono più, ai loro display che vivono di luce propria, tanti fuochi
fatui a illuderci e a infonderci sicurezza.
Come al solito non so niente di quello che andremo a
sentire, sono anni che l’accompagno a questi eventi, anni che mi annoio e mi
sforzo di apprezzare, senza risultati: io questa musica non la sopporto, che
sia classica, rinascimentale, barocca, contemporanea, dodecafonica atonale
seriale spettrale non fa differenza, e non lo so il motivo, non la capisco, non
mi entra nella testa, non è per me, che sia un’orchestra o un pianoforte solo,
provo uno strazio di cui a volte mi vergogno ma che è puntuale al gesto del
direttore d’orchestra che inizia a muovere la sua bacchetta, parte la musica e
parte l’incantesimo contro di me, obbligato alla poltrona ad essere trafitto da
ogni movimento d’arco o fiato emesso, come se ogni musicista fosse d’accordo
sulla mia punizione, come un plotone d’esecuzione. E poi arriva anche Sergio,
uno degli ultimi amici che mi è rimasto, sempre in ritardo, con l’aria
trafelata di chi ha appena fatto chissà cosa, comunque molto più importante di
un appuntamento o di una serata fuori, ti può spingere ad un disprezzo tale da
volerlo morto, si butta sopra il suo posto e mi abbraccia con uno slancio che
mi infastidisce all’istante, poi saluta Lei dandomi una gomitata sul costato e
strusciando i suoi capelli che sanno di
fumo contro la mia faccia. Non resisto, mi alzo e dico di dover andare in
bagno, non chiedo neanche scusa a quelli che faccio alzare per uscire dalla mia
fila, ma poi non mi dirigo dove ho detto, esco dal teatro, non mi importa che
stia piovendo ancora più forte di quando siamo entrati, comincio a camminare
come se fossi sicuro della mia destinazione e invece vado a casaccio, giro per
vicoli che non conosco e metto i piedi ormai fradici in ogni pozzanghera che
incontro, sento di essere ormai zuppo dalla testa ai piedi e trovo finalmente
un bar in cui entrare. L’ingresso è da straniero che irrompe nel saloon in una
notte da lupi, senza però spolverino fradicio e soprattutto senza pistole e
cinturone, ad aver paura e imbarazzo sono io, pure se nel locale sono
praticamente solo. C’è il barista, c’è un televisore accesso alla sua destra in
alto e ci sono due clienti, vecchi, che guardano una partita di calcio,
finalmente qualcosa che mi piace. Chiedo se fanno anche da mangiare, l’uomo
dietro al bancone fa un cenno con la testa verso le pizzette e i panini
esposti. Mi dice che sono freddi, dico che non importa, che me ne dia un paio,
tonno e pomodori, e prosciutto e mozzarella, e poi una birra. La birra me la
devo prendere da solo mi dice, la macchinetta che la mesce non funziona, mi dà
l’apribottiglie e mi indica il frigo che sta affianco all’entrata. La prendo e
pago, mi siedo al tavolo accanto a quello dei due vecchi, dopo cinque minuti
che mastico capisco che è un’altra partita del cazzo di questo campionato di
merda, piacevolmente sorpreso di questi miei pensieri volgari, sono in ottima
compagnia tra l’altro, uno dei due vecchietti ripete a ogni fischio
dell’arbitro: “’sto cornuto!”, l’altro invece sta zitto, ma riesco a sentire
ugualmente un fischio, un sibilo, qualcosa che gli esce dalla bocca, qualcosa
che lo rende pietoso e inutile. Poi di birre me ne scolo altre quattro, tutte
prima che la partita finisca, e mi rimetto in strada con le idee confuse e
un’ansia mista al rigurgito della cena. Quando sono a casa, La trovo
addormentata in salotto, in una posizione sicuramente scomoda mezza distesa sul
divano, con una coperta che le è già scivolata via e le lascia le gambe a
prendere freddo. Mi avvicino e il suo trucco, sempre leggero, è chiaramente colato lungo le guance
attraverso le sue lacrime, io mi siedo per terra, appoggio la mia testa un poco
sotto la sua, mi sento un verme, adesso sono io a piangere e a macchiare la
pelle del divano con le mie lacrime indegne, false, escono per inerzia,
scacciate dal mio corpo che vuole restare vuoto, assente.
Non mi ritrovo in questo, non cerco spiegazioni e non voglio
spiegarmelo, il mio gesto non ha bisogno di nessuno, di niente. Quello che mi
resta da fare è andarmene perché sono questo, ho esaurito le riserve di
energia, o le ho smarrite, non importa, e non sto cercando neanche altro, non
sto andando in cerca del mistero, dell’autentico o dell’aldilà, mi rimane solo
un’idea di futuro ed è quella di finirla al più presto, da solo e senza
possibilità di essere trovato, di essere disturbato, sento quest’estraneità
sulla pelle, mi sento di troppo. E certo che la mia solitudine è straziante e
mi appassisco e sono pieno di dubbi, chi è che se ne va con il sorriso in
faccia?
Ma non è solo avendo a che fare con dei fallimenti che si
perde la voglia di vivere, che siano fallimenti materiali o dettati dalla
vergogna, dalla mancanza di autostima, da una fragilità interiore che vediamo
fare a pezzi dagli sguardi degli altri, anche se nessuno ci ha mai rimproverato
di non essere adeguati, non è solo da questo che nasce un’idea del genere. E
non nasce all’improvviso, non lo ritrovo il momento che mi ha guastato, il
fatto che mi ha spinto verso un’altra direzione.
Sono in un treno, il vagone che mi ospita è vuoto, mi
assomiglia, ha una parte viva all’interno eppure non conta. L’incedere del
treno è lento, pare che stia salendo, dai finestrini scorgo un immenso bianco
disturbato dai tralicci dell’elettricità e da qualche volo isolato d’uccello.
Allora mi spingo meglio fino a schiacciare il viso contro il vetro per cercare
un particolare, uno qualsiasi su cui fissare lo sguardo, approfittare di questa
lentezza per ritrovare un tratto familiare, una testimonianza d’umanità, una
costruzione abbandonata. Adesso che sono abbastanza lontano da tutto, adesso
che avverto uno spazio rassicurante posso accettare la nostalgia di ieri, sono
sicuro che quando scenderò da qui le gambe non mi cederanno.
Così avanzo, senza perdere tempo, muovo i miei passi in un
ambiente inaspettatamente calmo, la neve mi ostacola ma non mi trattiene, sono
stanco e sbuffo, così poco abituato a muovermi all’aperto da non ricordarmi
l’ultima uscita, ed è l’unico rimpianto, che mi sono sempre mosso poco, il meno
possibile, ho sempre preferito un qualsiasi mezzo di trasporto alle mie
gambe, però avanzo. Alzo lo sguardo per
controllare la via, ma è inutile in effetti, non c’è nulla contro cui andare a
sbattere e la strada non finisce, mi asciugo il sudore che ho sulla fronte e
finisco per perdere l’equilibrio di
fronte a tale vastità, colori indefiniti, tra il bianco e il grigio; la fatica
aumenta, il suono prodotto dal mio incedere e il cuore che si ostina ad
aumentare la sua corsa, ho dolore alle orecchie e in bocca avverto uno
sgradevole sapore di sangue, i miei denti adesso sono di troppo. Il livello
della neve è aumentato e non me ne sono accorto, ormai sprofondo quasi fino alla
vita, mi posso fermare, mi lascio cadere in avanti e affondo le braccia e la
testa, urlo per il ghiaccio che passa attraverso i miei abiti lungo il collo e
la schiena, urlo dapprima mentre sono ancora immerso e poi urlo al cielo, urlo
fino a che la gola non chiede riposo. Respiro e piango, ansimo per tutto, la
fatica e il dolore, cos’è che mi lascio dietro? Quanti pensieri che
s’azzuffano, ognuno a reclamare attenzione, ma sono troppe le cose che uno
abbandona, sono così tante che le lacrime non bastano a piangerle tutte, e poi
infine le persone a me care, quanto sangue dovrebbe uscirmi adesso, quanta neve
dovrei macchiare per provare ciò che sto perdendo, e non lo voglio ammettere, e
non lo avrei ammesso di fronte a nessuno, ma mi mancano, non lo sa nessuno, non
lo può sapere questa neve, non lo potrà diffondere questo vento che mi schiaffeggia,
è tale la distanza che le mie urla adesso non arrivano più da nessuna parte, la
mia voce ha perso ogni suo senso, è sola con me a rispondermi e a urlarmi
contro. La distanza è pari alla misura
che era colma, ma se le metto a confronto non c’è dubbio che la prima fa più
male, dalla prima non guarirò più e adesso me accorgo, ho ancora tempo per
pensarci e per far crescere la disperazione, mi rimane tempo spero per
impazzire, per dare sfogo a questo lamento che sta salendo, il mio spirito
devastato in preda all’isteria e le mie membra congelate, che si preparano
all’assideramento, finalmente alla mia morte, avverto il contatto tra la mia
pelle e il mondo, tolgo ogni oggetto inutile, ogni vestito che mi separa dal
resto e mi preparo. Non sono in grado di andare oltre, mentre tremo non mi
viene più nulla, quand’è che finisce? Quanto manca, quanti istanti di
sofferenza mi separano dall’andare a fondo, dal poggiarmi a terra ricoperto di neve nel mio letto nuovo, calmo
e immobile, immenso e tutto per me, disponibile ad accarezzarmi, a farmi
sentire protetto e in salvo, a casa.
 Due film sul finire dell’anno, uno piuttosto famoso, l’altro
molto meno, anche perché non so neanche se sia stato distribuito in Italia,
comunque si trova in originale e si trovano pure i sottotitoli in italiano.
Boogie Nigths perché è scanzonato per buona parte, sono oltre due ore che
filano che è un piacere, Daisy Diamond perché al contrario è raggelante, parte
male e finisce peggio, ma lo fa con freddezza e rigore. Il protagonista di
Boogie Nights è un giovincello ben messo là dove una certa cultura mascula
asserisce che sia d’uopo essere ben messi. La protagonista di Daisy Diamond è
una giovane attrice con una brutta storia alle spalle che passa di provino in
provino, subendo meschinità e quant’altro, con una figlioletta che non smette
mai di piangere ( e che fa venire voglia a tutti credo una certa idea ). Il
mondo raccontato da Paul Thomas Anderson è quello del porno americano ( qua ci
starebbe tutto citare il reportage sugli oscar del porno di… ) nel passaggio
dagli anni ’70 agli anni ’80, un periodo interessante perché c’è stato il
passaggio dalla pellicola e quindi dai film fatti per il cinema, ai film in
cassetta. Un passaggio citato anche nel Grande Lebowski, quando Jackie Treehorn
lamenta la perdita dei sentimenti ( mannaggia mannaggia ). Non sono un cultore
del genere, quindi non saprei dire cosa è effettivamente cambiato e cosa no, al
di là delle specifiche tecniche, certamente una minore qualità da un punto di
vista filmico, meno attenzione alla storia ( ovvio che fa ridere detta così ) e
via dicendo. Ci saranno pure saggi interessanti in tema, magari un giorno
farò una ricerchina. La cosa buffa è che in Boogie Nights, il personaggio che
fa il regista sogna che il pubblico veda i suoi film non solo per andare al
cinema a farsi le seghe ( dico, gente, a pensarci mi vengono i brividi, però è
strano, pure in Caro Diario Moretti si lamenta dei tipi in tuta che si vedono i
film in casa e ormai non escono più; e quindi anche nel mondo del porno si
registra questo cambiamento sociale, dal pubblico al privato, non si
condividono più neanche le seghe, che brutto mondo ), ma che resti o che comunque
si interessi a tutta la storia. Che in fondo è semplicemente fare dei bei film
con le scene di sesso vere, come in Shortbus ad esempio. Boogie Nights è un
film corale, in cui ogni personaggio vive la propria ascesa e caduta, con le
occasioni che vanno e vengono un po’ a caso, che si intristisce ogni tanto, che
diventa pure efferato, ma senza essere duro, e dando un’altra occasione per
reinventarsi quasi a tutti. Certo, ha un po’ quell’effetto dei bei tempi andati
o del “poi sappiamo come sono andate le cose”, ma non ha praticamente punti
morti e diverte. E poi c’è la scena del capodanno che è fenomenale. Daisy
Diamond è più complesso nei rimandi e più spartano nel racconto, fisso sulla
protagonista, sulla sua discesa nella dannazione per purificarsi. È molto
didascalico per certi versi, nel seguire le varie fasi del dramma, però
impreziosito dal fatto che essendo un’attrice, la protagonista intreccia vita
reale e vita di scena ( in realtà provini, mai veramente in scena ), più vita
sognata e redenta. C’è una totale solitudine ( con un piccolo momento di
tenerezza e di confidenze ), un senso di squallore e di beffa crudele. È un
film forte che dà modo di riflettere su un personaggio, sulla sua storia. Il difetto
è che mi pare tutto molto aggiustato, e che anche se il dolore non viene usato
in maniera “ricattatoria” comunque sembra che stia lì per arrivare a dire
qualcosa di extra che non capisco.
Due film sul finire dell’anno, uno piuttosto famoso, l’altro
molto meno, anche perché non so neanche se sia stato distribuito in Italia,
comunque si trova in originale e si trovano pure i sottotitoli in italiano.
Boogie Nigths perché è scanzonato per buona parte, sono oltre due ore che
filano che è un piacere, Daisy Diamond perché al contrario è raggelante, parte
male e finisce peggio, ma lo fa con freddezza e rigore. Il protagonista di
Boogie Nights è un giovincello ben messo là dove una certa cultura mascula
asserisce che sia d’uopo essere ben messi. La protagonista di Daisy Diamond è
una giovane attrice con una brutta storia alle spalle che passa di provino in
provino, subendo meschinità e quant’altro, con una figlioletta che non smette
mai di piangere ( e che fa venire voglia a tutti credo una certa idea ). Il
mondo raccontato da Paul Thomas Anderson è quello del porno americano ( qua ci
starebbe tutto citare il reportage sugli oscar del porno di… ) nel passaggio
dagli anni ’70 agli anni ’80, un periodo interessante perché c’è stato il
passaggio dalla pellicola e quindi dai film fatti per il cinema, ai film in
cassetta. Un passaggio citato anche nel Grande Lebowski, quando Jackie Treehorn
lamenta la perdita dei sentimenti ( mannaggia mannaggia ). Non sono un cultore
del genere, quindi non saprei dire cosa è effettivamente cambiato e cosa no, al
di là delle specifiche tecniche, certamente una minore qualità da un punto di
vista filmico, meno attenzione alla storia ( ovvio che fa ridere detta così ) e
via dicendo. Ci saranno pure saggi interessanti in tema, magari un giorno
farò una ricerchina. La cosa buffa è che in Boogie Nights, il personaggio che
fa il regista sogna che il pubblico veda i suoi film non solo per andare al
cinema a farsi le seghe ( dico, gente, a pensarci mi vengono i brividi, però è
strano, pure in Caro Diario Moretti si lamenta dei tipi in tuta che si vedono i
film in casa e ormai non escono più; e quindi anche nel mondo del porno si
registra questo cambiamento sociale, dal pubblico al privato, non si
condividono più neanche le seghe, che brutto mondo ), ma che resti o che comunque
si interessi a tutta la storia. Che in fondo è semplicemente fare dei bei film
con le scene di sesso vere, come in Shortbus ad esempio. Boogie Nights è un
film corale, in cui ogni personaggio vive la propria ascesa e caduta, con le
occasioni che vanno e vengono un po’ a caso, che si intristisce ogni tanto, che
diventa pure efferato, ma senza essere duro, e dando un’altra occasione per
reinventarsi quasi a tutti. Certo, ha un po’ quell’effetto dei bei tempi andati
o del “poi sappiamo come sono andate le cose”, ma non ha praticamente punti
morti e diverte. E poi c’è la scena del capodanno che è fenomenale. Daisy
Diamond è più complesso nei rimandi e più spartano nel racconto, fisso sulla
protagonista, sulla sua discesa nella dannazione per purificarsi. È molto
didascalico per certi versi, nel seguire le varie fasi del dramma, però
impreziosito dal fatto che essendo un’attrice, la protagonista intreccia vita
reale e vita di scena ( in realtà provini, mai veramente in scena ), più vita
sognata e redenta. C’è una totale solitudine ( con un piccolo momento di
tenerezza e di confidenze ), un senso di squallore e di beffa crudele. È un
film forte che dà modo di riflettere su un personaggio, sulla sua storia. Il difetto
è che mi pare tutto molto aggiustato, e che anche se il dolore non viene usato
in maniera “ricattatoria” comunque sembra che stia lì per arrivare a dire
qualcosa di extra che non capisco.